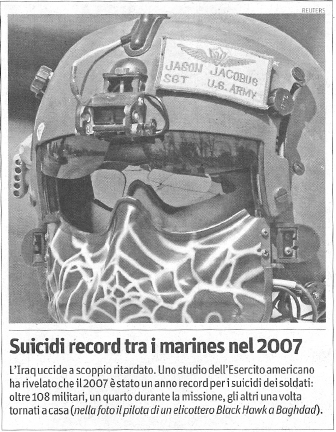
Dal Dossier del Che Fare n.° 70 gennaio febbraio 2009
È la fine dell’ordine a stelle e strisce!
La crisi finanziaria che ha contagiato in un baleno i cinque continenti è esplosa negli Stati Uniti. Tutto il mondo ne ha preso nota. E quasi ovunque gli stessi ambienti ufficiali, da Sarkozy a Hu Jintao, ne hanno attribuita la responsabilità primaria agli Stati Uniti.
Era inevitabile, dal momento che proprio lungo l’asse Washington-New York sono state varate, perseguite e dettate all’universo mondo le politiche economiche, sindacali, militari, culturali che hanno segnato il turbo-capitalismo degli ultimi trenta anni.
Il crack di Wall Street annuncia il tramonto degli States come "modello da imitare". Come guida riconosciuta del mercato mondiale, del capitalismo mondiale. E questo tramonto dà al caos attuale il carattere di un vero e proprio passaggio d’epoca. Perché cede, piegandosi su sé stesso, il pilastro fondamentale dell’ordine capitalistico internazionale dell’ultimo secolo. Salvo, s’intende, sempre possibili restauri e rilanci. Da non sottovalutare.
Ogni progresso nella costruzione del mercato capitalistico è stato accompagnato, protetto e talvolta anticipato dall’azione di uno o più potenti stati nazionali. E ogni fase storica di diffusione particolarmente dinamica del modo di produzione capitalistico ha goduto della malleveria di stati di crescente potenza. Lungo il secolo diciannovesimo tale funzione fu svolta dalla Gran Bretagna. Nel ventesimo è passata al primo mega-stato capitalistico (a stelle e strisce) avente l’ambizione e, per un buon tratto, anche i mezzi per dominare l’intero globo.
Un modello di società (e di ordine internazionale)
Gli Usa acquisirono questo dominio per mezzo della propria industria (Ford, General Motors, la Standard Oil e le altre sorelle petrolifere, U.S. Steel, Boeing, General Electric, etc.); della propria superiorità tecnologica; delle proprie armi di distruzione di massa, quelle vere, usate ad Hiroshima e Nagasaki, non quelle inventate da Colin Powell allo scopo di poter occupare e saccheggiare l’Iraq; ed infine, non per ultimo, per mezzo del re-dollaro, incoronato a Bretton Woods come moneta degli scambi internazionali. Dal 1945 in poi, il dominio industriale, scientifico-tecnologico, termo-nucleare, monetario si completò con una duratura egemonia politico-culturale. Gli Usa ebbero ferro e denaro per diffondere ovunque, anche nella casa del proprio rivale "sovietico", il loro modello di società. La famosa società "aperta", fondata sulla libertà d’impresa e su tutto il catalogo delle libertà (formali) individuali. La società che, in base all’"eguaglianza delle opportunità", poteva consentire a ciascun individuo dotato di buona volontà e intraprendenza di affrancarsi dalla propria condizione di partenza; la società, dunque, della mobilità sociale ascendente, dei self made man. E nello stesso tempo una società che, proprio per effetto del grande dinamismo assicurato da questa concorrenza tra liberi individui e dalla ricerca scientifica di avanguardia, era in grado di raggiungere traguardi sempre più alti di benessere per tutti. Una società capace di socializzare la proprietà di una gamma crescente di beni di consumo dal costo crescente, in primo luogo l’automobile, un’automobile sempre più grande e potente, in crescendo fino alla casa, alla villetta monofamiliare. Una società della competizione inter-individuale, certo, ma che conosceva un solido compromesso tra capitale e lavoro, con un potente sindacato (aziendale), che assicurava ai propri operai i salari di gran lunga più alti del mondo (1). E perciò una società nella quale, passo dopo passo, i confini tra le classi si facevano sempre più sottili e superabili, in una tensione, del tutto nuova per la modernità, verso la "one class society", la società di una sola classe sociale, la società di soli ceti medi.
Di questo modello di società Washington si fece banditrice universale. Forti della loro vittoria in guerra contro le dittature nazi-fasciste, gli Stati Uniti sollevarono davanti a tutti i popoli, con una legittimazione maggiore che nel 1918 (grazie anche all’alleanza con la Russia di Stalin), l’insegna della autodecisione dei popoli, della loro indipendenza politica dai vecchi poteri coloniali europei e giapponesi, l’insegna della libertà e della democrazia alla scala universale. Che, con qualche astuto anticipo in contanti (per esempio il prestito alla Jugoslavia di Tito) e la grancassa incessante delle istituzioni dell’Onu installate a New York, divenne anche l’insegna dello sviluppo universale di tutte le nazioni secondo un’astratta tappistica (quella delineata da W. Rostow) mutuata dal caso americano. Non meno importante del sostegno dell’Onu fu la collaborazione, in Europa, dei partiti socialdemocratici, sia dentro che fuori le istituzioni della Nato.
Società aperta, democrazia, ostilità alle dittature, "anti-colonialismo", apertura di sempre nuove frontiere di sviluppo per tutti i popoli: tutto ciò fece dell’America (2) un punto di riferimento nel secondo dopoguerra, perfino per lo stesso avversario "sovietico". Imitare l’America, raggiungere l’America e, nei sogni à la Krusciov, superare l’America sul suo stesso terreno del quantitativo crescente di produzione materiale: nei paesi più sviluppati, inclusi quelli "socialisti", non si è parlato d’altro per decenni. L’America modello di sviluppo, di mobilità sociale. L’America perno di un ordine internazionale stabile e dinamico, capace di inglobare sempre nuovi paesi. L’America, perciò, nazione indispensabile, faro dell’intera umanità. Soprattutto per le classi proprietarie e i benestanti con la pelle bianca, of course. Pienamente rassicurate dal fatto che una tale super-nazione avesse il quasi-monopolio delle armi nucleari, e potesse così soppiantare adeguatamente il vecchio colonialismo con un colonialismo finanziario e termo-nucleare nuovo di zecca, capace di tenere a bada i popoli delle ex-colonie in ascesa.
Ma un primo formidabile colpo a questa egemonia venne proprio dal mondo dei paesi dominati e controllati. Lo diede la sconfitta patita dall’imperialismo Usa in Vietnam. Lì il "buon" zio Sam fu smascherato nella sua pretesa di considerare il mondo intero il proprio cortile di casa, e di affermare in modo dittatoriale la sua legge e il suo sfruttamento ovunque. Con la loro guerra di liberazione nazionale i vietnamiti "spiegarono" ai lavoratori e ai popoli oppressi del mondo che la statua della libertà altro non era che l’ingannevole effigie di un imperialismo spietato e rapace almeno quanto quelli al tramonto, solo infinitamente più ipocrita. L’America, la grande inquisitrice di tutte le "dittature", la protettrice suprema delle istanze di autodecisione dei popoli, fu sbattuta sul banco delle potenze schiaviste assassine della libertà dei popoli. E divenne per grandi masse di giovani e di proletari il paese dei defolianti, dell’Agente Orange, dei bombardamenti indiscriminati sulle popolazioni civili in lotta per la loro terra. In una parola: l’imperialismo yankee. Da odiare e combattere. L’egemonia statunitense ne fu scossa nella stessa America Latina dei governi gorilla e del golpe militare anti-Allende a regia statunitense. Anche perché, nei medesimi anni, all’interno degli States i movimenti dei neri e dei giovani portarono alla luce tutto il razzismo, l’autoritarismo, la tolleranza repressiva (per dirla con Marcuse), la reificazione insiti nel "buon modo di vivere" americano.
Le traversie del re-dollaro e del sistema monetario creato a Bretton Woods, legate strettamente alla prima cocente disfatta del Pentagono, fecero il resto. Nel 1944, con gli accordi di Bretton Woods, il dollaro soppiantò anche formalmente la sterlina come moneta degli scambi internazionali, e divenne l’unica moneta internazionale convertibile in oro. Le altre monete furono obbligate a mantenere una parità fissa, cioè un termine di cambio fisso, nei confronti del dollaro. Ma nel 1971 Nixon dichiarò il dollaro non più convertibile in oro (la convertibilità era già cessata di fatto nel 1968), ammettendo così il suo oggettivo indebolimento (ci fu anche una sua svalutazione formale del 10%). Il bastione dell’ordine monetario prodotto dalla seconda guerra mondiale non era più stabile come nel 1944. Ma il mondo venne subito rassicurato: il dollaro sarà come un oro cartaceo, solido quanto l’oro metallico. Non essendovi alternative, vi credette. O finse di credervi.
La reaganomics e il neo-liberismo
Fortuna volle, per Washington, che la crisi politico-monetaria degli Stati Uniti di fine anni ’60-inizio anni ‘70 fosse soverchiata nel biennio 1974-’75 dalla prima seria crisi produttiva generale dei paesi occidentali nella seconda metà del ventesimo secolo. Per i capitalisti di tutto il mondo fu naturale e necessario rivolgersi di nuovo alla superpotenza economica n. 1 per chiederle di trarre fuori dal pantano l’economia internazionale (in realtà la superpotenza aveva già fatto un primo passo in questa direzione con la "inaudita" apertura di Nixon e Kissinger alla Cina di Mao). E di lì a qualche anno Washington esaudì la richiesta trovando la bussola "giusta" con la reaganomics, la politica economica varata dall’amministrazione Reagan all’inizio degli anni ’80, e la deregulation finanziaria.
L’ideologia di questa politica economica fu fornita dalla scuola neo-liberista. Diciamo ideologia, e non semplice dottrina economica, perché questa scuola si è segnalata anzitutto per una aggressiva difesa della proprietà privata, del mercato, della concorrenza tra imprese e tra individui come veri e propri intoccabili principi fondativi, imperativi morali della società contemporanea. Essa bollò il conflitto sociale, la lotta di classe (solo quella del proletariato, si capisce) e il socialismo come forme di primitivismo e di irrazionalità. Dopo essere rimasta in ombra durante il ciclo post-bellico, guadagnò posizioni su posizioni dopo la crisi degli anni ’70, di cui fornì una spiegazione diventata egemone anche nella socialdemocrazia europea à la Mitterand, alla Blair, alla D’Alema, alla Schroeder. Le cause del blocco dello sviluppo post-bellico? Elementare: lo strapotere dei sindacati e del movimento operaio e la conseguente crescita della spesa sociale. Per uscire dalle sabbie mobili della stagflazione e degli scarsi profitti bisognava quindi ridurre i salari, tagliare il "parassitismo" del welfare, privatizzare il privatizzabile, ripristinare il saggio "naturale" (!?) di disoccupazione, smantellare il potere sindacale, segare le imposte sui redditi alti e i profitti delle società, introdurre una nuova, salutare disuguaglianza sociale per stimolare la ripresa della profittabilità.
Il primo campo di applicazione sistematica del neo-liberismo fu, per opera dei "Chicago boys", il Cile insanguinato di Pinochet: uno stato dal pugno di ferro è essenziale alla messa in opera di queste politiche che si vogliono "liberali" e "liberatrici" ma hanno in realtà uno smaccato segno autoritario e anti-proletario. La fermezza di Reagan contro i controllori di volo statunitensi, della Thatcher contro i minatori inglesi, di Craxi contro gli operai mobilitati in difesa della scala mobile, furono le prime trasposizioni vincenti in Occidente di questo indirizzo. Che giorno dopo giorno acquistò proseliti militanti nei mandarini del capitale globale, al Fmi e alla Banca Mondiale, all’Ocse e nel Gatt, nelle università e nel sistema dei mass media. Il crollo del "socialismo reale" incoronò l’ortodossia neo-liberista come la sola forma di pensiero economico-sociale razionale, e ne rafforzò le spinte più estremistiche. Pensiamo, ad esempio, all’abbattimento dei salari e di ogni forma di garanzia nei paesi dell’Est Europa nel dopo-1989, che sta avendo crescenti ripercussioni negative pure sui lavoratori dell’Europa occidentale. Sintomatico quanto disse una decina di anni fa l’attuale presidente della Cechia, V. Klaus: "Il sistema sociale dell’Europa occidentale è esageratamente prigioniero di regole e controlli eccessivi. Lo stato sociale, con i suoi generosi trasferimenti di denaro non soggetti a condizioni, non condizionati agli sforzi o ai meriti dei beneficiari, distrugge le fondamenta morali del lavoro e il sentimento della responsabilità individuale. I dipendenti statali [in particolare] sono troppo protetti. Bisogna dire che oggi la rivoluzione thatcheriana, anti-keynesiana e liberale, si trova in Europa occidentale in mezzo al guado. È necessario condurla sull’altra riva." (3 )
I fantocci est-europei dell’anti-comunismo filo-yankee alla Klaus hanno fatto di tutto e di più per giocare loro il ruolo di primi della classe (nel campionato interregionale…); ma a condurre sull’altra riva, a portare al trionfo la "rivoluzione" neo-liberista è stato ovviamente l’asse Washington-Wall Street. Sia perché ne ha imposto la diffusione universale attraverso le istituzioni-cardine della "costruzione sociale del mercato" globalizzato, tutte poste sotto il suo padrinaggio (G-7, Fmi, Wto). Sia perché è stato il motore primo della deregolamentazione dei mercati finanziari, dei movimenti internazionali dei capitali e delle monete, della creazione di prodotti finanziari sempre più futuristici e truffaldini. Sia infine perché è intervenuto con l’arma bellica ogni volta che la resistenza di singole nazioni (Iran, Iraq, Jugoslavia, Sudan, Afghanistan, etc.) è sembrata minacciare o intoppare questa diffusione. Neo-liberismo e politica (e ideologia) di guerra neo-cons sono le due facce della stessa medaglia, passata internazionalmente di successo in successo fino alla catastrofe finale di ottobre.
Il compromesso sociale e internazionale (l’equilibrio della guerra fredda) del secondo dopoguerra non venne formalmente dichiarato morto e sepolto, ma gli avvenimenti interni ed esterni agli Stati Uniti hanno certificato ormai questa fine, e con essa un vero e proprio passaggio d’epoca.
Una società spaccata in due
Il nuovo modello di società, infatti ha avuto i più profondi riflessi sulla società statunitense e sul suo ruolo di prima potenza mondiale.
L’imperativo primo della "religione neo-liberista", abbattere il prezzo della forza-lavoro, ha trovato negli Stati Uniti un’applicazione spietata da parte del management aziendale, con risultati tangibili nel tempo in termini di crescita della produttività del lavoro. Il tasso di crescita medio del periodo tra il 1975 e la metà degli anni ’90, intorno all’1,4% annuo, è stato largamente superato negli anni 1995-2000 con un +2,5% annuo, e poi addirittura doppiato nel periodo 2000-2005 (+3,1% l’anno). Per contro, in tutto l’arco del trentennio i salari reali statunitensi hanno avuto un solo intermezzo di crescita con la seconda presidenza Clinton, a fronte di una lunga accentuata discesa dal 1978 al 1996 e di una nuova lieve discesa dopo il 2000, accentuatasi negli ultimi due anni. Il taglio più pesante è stato quello del salario minimo, che ha perso ben il 25,7% del suo valore tra il 1960 e il 2005 (4); un ruolo oggettivo importante in questo abbassamento l’ha avuto l’uso padronale ricattatorio di una nuova massiccia immissione di forza-lavoro immigrata dai paesi dell’America centro-meridionale, in larga misura "illegale".
L’enorme trasferimento della ricchezza sociale dal lavoro al capitale che ne è derivato ha prodotto negli Usa la polarizzazione sociale più accentuata dagli anni ’30. È stata una doccia fredda sulle aspettative di benessere non solo della massa dei lavoratori salariati dei livelli più bassi, ma anche di ampi strati intermedi della mitica middle class. Non staremo qui a ripetere le cifre sulla ricchezza rapinata dai boss delle corporations con i loro super-contratti e le loro mega-liquidazioni. Di sicuro li avrete letti da qualche parte. E per noi comuni mortali sono talmente stratosferiche da apparire lunari, "insignificanti". Notiamo invece che, in aggiunta a tutto il resto, il probabile cedimento dei fondi pensioni darà un colpo devastante ai bilanci di decine di milioni di famiglie statunitensi: o perché ridurrà le entrate da pensione, o perché, per tutelare in qualche modo la futura pensione, obbligherà tanti a versare contributi aggiuntivi ai propri espropriatori. In questo modo, con milioni di licenziamenti, il balzo in avanti della disoccupazione, la compressione ulteriore del salario medio, il quadro (nerissimo) sarà completo.
Tutto ciò annuncia tempesta sociale e politica nel cuore degli Stati Uniti. Per la classe lavoratrice multirazziale d’oltre Oceano la sola alternativa ad un abisso inimmaginabile di sacrifici, di povertà e di durissimo ulteriore incremento dei carichi di lavoro sarà il ritorno in grande alla lotta di classe anti-capitalista, un nuovo corso del movimento proletario. I lavoratori statunitensi dovranno di necessità difendersi in modo militante e organizzato dal crepitare delle armi avversarie. E in questa lotta di auto-difesa potranno, dovranno riaprire gli occhi sul fatto che il capitalismo, specie negli Usa, ha già dato tutto quello che poteva dare. Ora è tempo di dichiarargli guerra. Dall’interno stesso degli States. Per aprire la via ad un’altra America. Ad un altro mondo, liberato dagli avvoltoi e dai piranha delle borse e delle banche, ma anche dalla proprietà privata e dallo sfruttamento capitalistico di cui costoro sono figli. Se nel centro dell’"impero dell’abbondanza", nel pieno della grande rivoluzione tecnica informatica, riprendono corpo gli antichi incubi della povertà di massa e della fame, quale migliore prova potrebbe esserci che l’antagonismo tra le capacità produttive del lavoro umano associato e i rapporti sociali capitalistici è giunto al punto massimo di esplosività?
Un impero "a credito", con credito… scarseggiante
Solo noi marxisti abbiamo saputo antivedere l’arrivo di questo momento storico. Che giunge, non a caso, nel punto di massima debolezza relativa dell’imperialismo a stelle e strisce nei confronti dei concorrenti vecchi e nuovi, e dei paesi dominati.
La globalizzazione finanziaria, infatti, nell’accrescere la dipendenza di tutti gli attori economici, imprese e stati, dal mercato mondiale, ha accresciuto di molto anche la dipendenza degli Stati uniti "dall’esterno". Oggi, 2008, quello che al 1945 era il massimo creditore della storia del capitalismo, capace di fare anticipi all’Europa e all’Asia, quello che ancora al 1971 deteneva la moneta regina incontrastata del sistema monetario internazionale, si è trasformato in un "impero a credito", nello stato che ha la massima esposizione ai finanziamenti esteri per via dei suoi deficit, commerciale, dei pagamenti e statale. Gli Stati Uniti di oggi sono dipendenti, dall’estero, quali mai in passato, per il loro debito pubblico, per le fonti di energia, per le merci. Dipendenti nella veste di debitori, non di creditori, come nel 1945. Il disavanzo delle partite correnti è il più alto dell’ultimo secolo di tutti gli stati occidentali (se si eccettua l’Italia del 1924). Non è da meno il deficit commerciale, che si è moltiplicato per sei in venti anni, e rimane, specie per la sua tendenza, pesantissimo, anche se lo si decurta di un 45% di merci prodotte da filiali estere delle multinazionali a base statunitense.
La deregulation finanziaria dell’ultimo ventennio ha foraggiato l’ordine politico-militare a dominio unilaterale statunitense. Ma per questo ordine è suonata la campana dell’ultimo giro. Il Council of Foreign Relations lo ammette: gli Usa sono in una situazione di vulnerabilità quale mai avevano conosciuto in precedenza. I suoi primi creditori sono infatti le banche centrali di Cina, Giappone, degli stati petroliferi arabi, nonché i fondi sovrani che fanno capo a questi stati: cioè al "competitore strategico" degli Usa, a uno dei suoi massimi concorrenti e ad alcuni vecchi stati amici un po’ meno amici oggi di ieri, e comunque sempre meno disposti –lo si è visto con la guerra in Afghanistan- a finanziare le guerre made in the Usa. Già prima che Lehman Brothers e le altre consorelle avessero il tracollo, il massimo organismo di geo-politica statunitense prevedeva che la Cina e gli altri creditori avrebbero, pur cautamente, ridotto la propria esposizione in titoli del tesoro statunitensi ben poco remunerativi. A maggior ragione ciò avverrà ora che tutti questi stati, nessuno escluso, hanno da fronteggiare i contraccolpi interni della crisi mondiale. Né sarà agevole per Washington trovare in giro per il mondo nuovi sottoscrittori privati per i propri sbilanci in crescita esponenziale (in 15 giorni i provvedimenti urgenti messi in cantiere da Obama sono lievitati da 175 a 500 miliardi di dollari…). A meno di promettere loro rendimenti ben superiori a quelli assicurati agli investitori istituzionali. A meno – quindi – di far lievitare ulteriormente il debito statale e, con esso, la dipendenza dall’estero.
Ancora nel 1991 Bush padre prometteva come contropartita un nuovo piano Marshall ai volonterosi traditori della causa araba che avessero appoggiato la distruzione dell’Iraq. I volonterosi traditori arabi non mancarono. Mancò, invece, il promesso piano di sviluppo. Ridicolo sarebbe aspettarselo oggi per l’universo mondo coinvolto nell’11 settembre di Wall Street da un’America che ha ristretto la sua base industriale interna, che è super-indebitata, che è la massima importatrice mondiale di idro-carburi (nel 1929 era autosufficiente), e che con le sue guerre non vinte a catena, ha perso prestigio perfino come poliziotto universale.
Il boomerang è tornato a casa
L’imperialismo a stelle e strisce è oggi parte del problema, assai prima che della sua soluzione. Anche perché paga l’enorme discredito della nuova finanza, delle vecchie banche, delle società di rating, delle autorità di controllo, della stessa "libera economia di mercato". E non minore è il discredito di cui si è coperta l’ideologia neo-liberista. Il "potere di seduzione" politico-culturale del "modello yankee" non è mai stato così basso. Nel Sud del mondo e nella stessa Europa. La pretesa statunitense di avere democratizzato fino all’estremo limite il possesso delle azioni, di avere portato la maggioranza delle famiglie statunitensi oltre la proprietà dell’auto e della casa, addirittura alla proprietà di pacchetti azionari (5), di avere socializzato, popolarizzato il capitalismo, si è svelato per quello che realmente è: un crudele bluff. Alla resa dei conti si è visto come nei favolosi anni della finanziarizzazione dell’economia non è stato certo l’americano comune a entrare nelle stanze dorate della finanza, facendosi azionista; è stato invece il capitale finanziario ad entrare e spadroneggiare più che mai nelle case e nella vita delle famiglie statunitensi di oggi, di domani, di dopodomani.
Le mirabolanti promesse della reaganomics e del neo-liberismo si sono trasformate così in un boomerang che ritorna ora sul sistema finanziario, politico, militare e propagandistico da cui erano partite. I missili che oggi, compiuto il giro del mondo, colpiscono Washington e New York sono stati lanciati trent’anni fa proprio da Washington e da New York. Ma sarebbe da ingenui credere ad un qualcosa che assomigli ad una resa, ad un volontario semi-dimissionamento dal ruolo dominante che gli Stati Uniti hanno ricoperto per un secolo. La super-potenza non è diventata d’un tratto un "paese normale". Giocando la carta Obama, rilancia la propria ambizione a guidare l’uscita dalla crisi. Come? Socializzando e mondializzando le perdite del capitale. Trasformando la grande crisi del capitale in una catastrofe del mondo del lavoro.
1) All’inizio degli anni ’70 il repubblicano Nixon vantava appunto che i salari industriali statunitensi fossero tre volte più alti di quelli tedeschi, a loro volta i più alti dell’Europa continentale.
Quanto al compromesso tra capitale e lavoro, non va dimenticato che nel 1947 la legge Taft-Hartley ne modificò i contenuti a tutto vantaggio delle imprese e dell’ordine costituito, in quanto vietò gli scioperi di solidarietà e le azioni di boicottaggio, e cioè ogni sciopero a valenza politica. Il solo possibile terreno di iniziativa sindacale ammesso in via legale restò, così, quello salariale. In realtà negli anni seguenti le burocrazie sindacali assunsero anche iniziative politiche, ma tutte e solo a sostegno del "proprio" governo e del "proprio" stato, dell’imperialismo a stelle e strisce, per es. a favore della criminale guerra al popolo vietnamita.
2) Sappiamo bene che per le popolazioni latino-americane è sbagliato, se non provocatorio, usare il termine America come sinonimo di Stati Uniti, ma lo facciamo qui intenzionalmente. Perché fa parte della strapotenza e della prepotenza yankee avere usurpato per sé, con successo, il nome America, dalla dottrina Monroe in poi.
3) Riprendiamo questa citazione e altri spunti dal dossier di "Page deux", octobre 1996, intitolato Histoire et leçons du neo-liberalisme.
4) Cfr. L. Mishel-J. Bernstein-S. Allegretto, The State of Working America 2006/2007, Economic Policy Institute, Cornell University Press, 2007, pp. 1, 190-1, 345..
5) Nel 1975 possedevano azioni il 16% delle famiglie statunitensi, mentre "a partire dalla fine degli anni Novanta, gran parte delle famiglie americane è diventata azionista, investendo i propri risparmi in borsa, nei piani 401 (k) o in altri piani pensionistici" (R. Reich, Supercapitalismo, Fazi, 2008, p. 114). Tuttavia l’azionista medio possedeva prima del crash "solo circa 5.000 dollari di azioni".
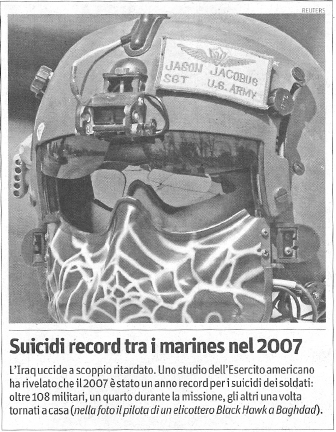
Dal Dossier del Che Fare n.° 70 gennaio febbraio 2009
ORGANIZZAZIONE COMUNISTA INTERNAZIONALISTA